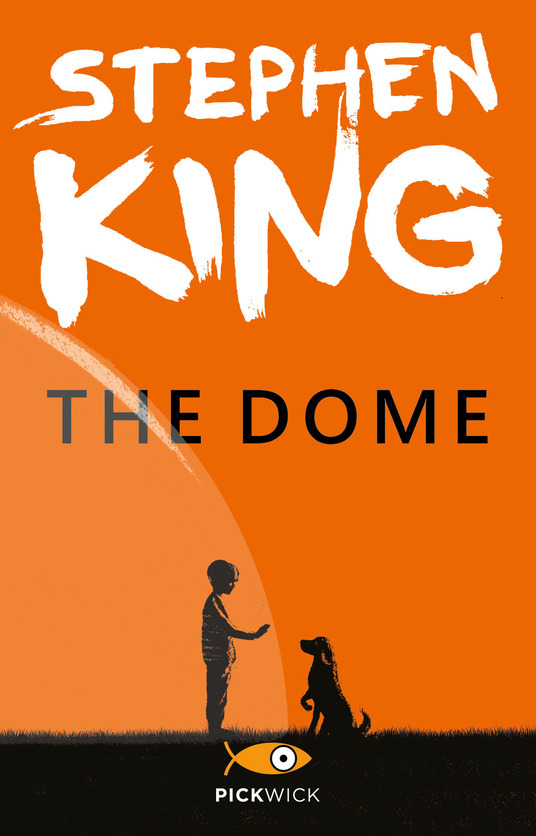
Nel 2009, dopo alcuni anni di mezzi successi (o parziali insuccessi), Stephen King uscì con ‘The Dome’.
Il Re era tornato.
Un ritorno atteso e che, a mio modo di vedere, ci ha regalato un King in stato di grazia. Un ritorno che andava a completare un percorso narrativo imperfetto iniziato nel 1978, con ‘L’Ombra dello Scorpione‘, perfezionato ma solo in parte nel 1985 con ‘La Nebbia‘ e finalmente completato, in maniera impeccabile, con ‘The Dome’.
La cittadina di Chester’s Mill una mattina si risveglia isolata dal mondo in seguito alla comparsa di una misteriosa cupola indistruttibile. Dopo lo sgomento iniziale e i vani tentativi dell’esercito di frantumare la gabbia trasparente, le cose prendono direzioni impreviste. I difetti della piccola comunità iniziano a emergere e la morte improvvisa e accidentale dell’unico collante autoritario e coerente della città (lo sceriffo) non farà altro che accelerare le pulsioni estremiste di alcuni abitanti.
La situazione è chiaramente estremizzata in modo elegante e pretestuoso. Già dalle prime pagine si capisce che il reale tema del libro non è il perché della Cupola e il come sia apparsa. Il tema sono le interazioni umane, la socialità, la reazione degli stereotipi moderni incarnati dai personaggi in una situazione estrema. Questo esperimento era stato tentato con ‘L’Ombra dello Scorpione’ (che resta un romanzo magnifico), ma il risultato aveva lasciato a desiderare, soprattutto nel finale. Troppi personaggi, forse, e una linea narrativa non così determinata.
Nel ‘La Nebbia’, King aveva tentato un esperimento più in piccolo ma al tempo stesso più in grande: interazioni tra persone bloccate in un supermercato a causa di un evento catastrofico. Le reazioni a una psicosi talmente particolare da risultare persino aliena.
In ‘The Dome’ King trova la sua dimensione. Una piccola cittadina, fisicamente isolata dal mondo ma in comunicazione con esso. Finalmente la chiave giusta per dimostrarci che gli stereotipi non sono una semplificazione della realtà: sono la realtà vera e propria. In situazioni estreme, lo stereotipo diventa scienza del comportamento e in modo molto Batman-Nolaniano, King si concentra su questo.
C’era, ne ‘La Nebbia’, l’accezione ottusa della religione estremizzata, c’era ne ‘L’Ombra dello Scorpione’ il senso di catastrofe apocalittica e distruttiva a livello globale..
In ‘The Dome’ c’è tutto, dal sociale al politico. Simbologicamente ha tanti di quei riferimenti da perderci nottate e le stesse interazioni, i comportamenti dello stereotipo estremizzato, sono un vero e proprio manuale sociologico.
Il finale, per quanto possa lasciare qualche perplessità, è il più giusto. Stiamo parlando di cosa succede, non di cosa dovrebbe accadere, non di cosa vorremmo accadesse.
Lo puoi trovare qui:

Non è facile inquadrare, per chi come me è appassionato di fantascienza, l’ultima fatica di Stephen King. Come non era facile appiccicare un’etichetta a ‘The Dome‘. E’ un pregio dei grandissimi scrittori mischiare le carte fino a fondere in maniera del tutto unica generi tra loro diversi e a testimonianza di questa capacità c’è proprio ’22/11/’63’.
Come in ‘The Dome’ era riuscito in pochissime pagine a creare una situazione estrema tanto da farci dimenticare il come era calata la cupola sulla città spostando la nostra attenzione su quello che accadeva al suo interno, così in questo romanzo ci spiega, rapido e conciso, che i viaggi nel tempo sono possibili. Non solo, che hanno regole logiche e stringenti: tornare nel passato più di una volta vuol dire cancellare tutto quello che si è fatto durante l’ultimo viaggio, il passato non vuole essere modificato e ci sono paradossi inquieti che sfidano ancora di più le leggi della fisica.
Ecco, questo è tutto quello che dobbiamo sapere prima di seguire Jake Epping, insegnante non ancora quarantenne, divorziato da una moglie alcolista e con pochi legami affettivi, nel suo viaggio verso il 1958. King è in grado di farci dimenticare subito che stiamo viaggiando nel tempo, è in grado di sospendere la nostra incredulità annientando tutte le teorie sullo spazio-tempo in cui ci siamo imbattuti e che abbiamo fatto nostre perché i suoi anni sessanta sono così veri da diventarci ben più che famigliari. Diventano una realtà desiderata e desiderabile, funestata solo dal male assoluto e dal tempo.
Il male King ce lo mostra, poco alla volta, attraverso due facce: quella aliena e horrorifica, e quella umana ma al tempo stesso non meno spaventosa. La prima indossa i panni di Derry, poco dopo la fine dell’incubo chiamato IT, proprio nel 1958. Jake Epping, il cui alter ego del passato si chiama George Emberson, arriva a Derry e incontra Beverly Marsh e Richie Tozier. Il modo in cui Jake ci descrive Derry, i suoi abitanti, il male che la corrompe da sempre e che sembra aver infettato ogni parte del tessuto cittadino è da pelle d’oca. Quando un autore cita se stesso in questo modo, vuol dire che ha raggiungo l’olimpo letterario.
La seconda faccia del male è quella che King stesso, più volte nei suoi precedenti, battezza ‘la fine dell’innocenza americana’. E’ una data. E’ Dallas, malata in modo diverso da Derry. E’ Lee Oswald e le sue liti domestiche. E’, insomma, il 22 novembre del 1963 e tutto quello che comporta arrivare a quella data.
Ma c’è anche molto altro. C’è un viaggio di Jake, adulto non ancora cresciuto, che vede nel ballo di Beverly e Richie la sua stessa salvezza. C’è il suo percorso di crescita, come in ‘Stand By Me‘ c’era il diventare uomini di quattro amici. Gli adolescenti sono sempre stati catalizzatori del bene per King ma questa volta, per affrontare il male più oscuro degli Stati Uniti, il protagonista è un uomo ‘ragazzo’. Gli adulti sono gli altri mentre lui, proprio come in ‘Stand By Me’, deve viaggiare nel tempo per ritrovare la sua purezza, per incontrare un bene così grande da riscattare ogni cosa.
Si innamora, Jake. E ’22/11/’63’ è più di ogni cosa un libro sull’amore. Su come due ballerini nati per ballare l’uno con l’altra possono incontrarsi in tempi diversi, in mondi diversi e su come possano, per pochi istanti, sospendere tutti gli orrori che devono essere affrontati con una determinazione che viaggia nel tempo.
Tutto quello che ci racconta King, tutti i suoi anni sessanta, la famigliarità che ci trasmette nei confronti di Oswald e di quegli inferni di povertà che sono Forth Worth e Dallas, sono pura narrazione. Ci racconta una storia di balli, tradimenti, menzogne, errori e orrori.
E la porta per mano fino alla sua conclusione fino a scrivere, forse per la prima volta, un finale più che all’altezza di tutto il romanzo. Il nuovo mondo del futuro è una delle distopie più distruttive che abbia mai letto e con un delicatissimo stratagemma riesce a chiudere alla perfezione uno dei tanti cerchi da lui aperti. Le ultime dieci pagine sono da straziare il cuore e strappano lacrime lasciando un malinconico desiderio di cambiare il passato. O di tenerlo così come lo abbiamo vissuto perchè non farlo sarebbe peggio. E’ un’equazione con una sola soluzione possibile.
Detto questo, qualche difetto, qualche calo di tensione, lo troviamo. I primi stratagemmi con i quali il tempo manifesta la sua inflessibilità sono un po’ troppo artificiosi e questo è un peccato perchè poi King riesce ad armonizzarsi e a trovare una giustissima dimensione del passato e delle sue potenzialità. In più chiude un po’ in fretta il paradosso del tempo, l’enigma con l’uomo dalla tessera verde e il collegamento con la teoria delle catastrofi. Ma, come dicevo, non è di questo che King vuole parlare e se ci spiega tutto quando lo fa quasi per farci un favore.
Non abbiamo bisogno di sapere troppo. Quando siamo alle ultime pagine non ci interessa nemmeno più sapere il perchè di molte cose. Ci sono Jake, ci sono Sadie. C’è la danza, c’è il rimpianto, c’è il dovere e c’è quello che è giusto.
Tutto sfocato dalle nostre lacrime.
Lo puoi trovare qui:
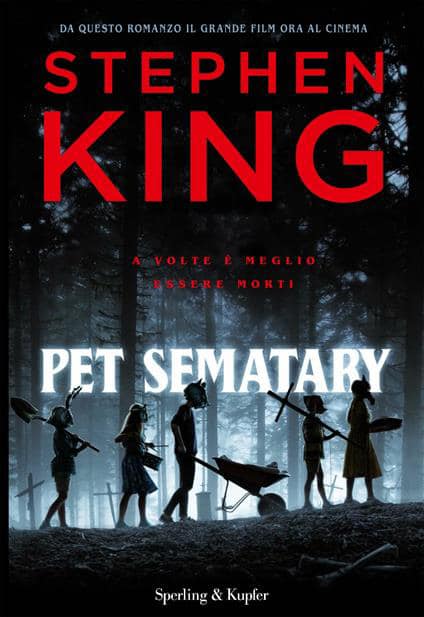
“Probabilmente sbaglia chi crede che vi sia un limite all’orrore che la mente umana può sperimentare. Al contrario, per quanto possa dispiacere ammetterlo, l’esperienza umana tende, per molti aspetti, a confermare che, quando l’incubo diventa sufficientemente cupo, orrore dà origine a orrore, un male fortuito genera altri e spesso più deliberati mali, finché la tenebra sembra ricoprire tutto. E l’interrogativo più agghiacciante potrebbe essere, forse, quanto orrore la mente umana può sopportare pur conservando un equilibrio vigile, attento, implacabile.”
Durante la lettura mi sono chiesto più volte cose avrei provato nell’affrontare Pet Sematary in quei lontani anni ‘80, da adolescente. Mi sono chiesto quante notti insonni avrei trascorso dopo aver accompagno Louis Creed su quella montagna addobbata di rami morti e poi oltre la Palude, fino al cimitero dei Micmac. Non lo saprò mai, ma so cosa ha voluto dire leggere Per Semetary da adulto.
Più di tutto in questo romanzo ci sono la morte, la paura della morte, il rifiuto della morte. E un profondo senso di colpa che scaturisce dal non saper accettare – o dall’aver accettato – l’orrore di una vita che si spegne. Perciò, cosa porterò con me? Non il terrore per la paura dell’ignoto. Quello no. Ma il fragore della mente di Louis Creed che si spezza, l’assordante rumore delle ossa di una mitologia antica e cattiva che cercano in tutti i modi di saldarsi allo carne del presento. Questo sí, questo lo porterò con me. E anche la tentazione di una possibilità inconfessabile. La disperazione della consapevolezza, di vedere il proprio futuro imboccare la strada sbagliata ma di non poter – e non voler – fare niente per evitarlo. E il limite e il superamento di quel limite.
King scava tra i ricordi, le speranze e le paure di Louis. Scolpisce a fondo, prepara una comoda poltrona fatta di memorie, sangue e muscoli e ci invita a sederci proprio lí. Al centro di quel crocevia inconfessabile dove il cuore di un uomo incontra orrori innaturali capaci di portarlo dove non avrebbe mai dovuto andare. E la razionalità di Louis, di Ellie, di Jud e di Rachel si ribella condensandosi in un istinto primordiale che però non può nulla contro la possibilità così profonda come quella di trasformare in transitoria l’eternità della morte. Non possiamo vincere perché questi poteri, queste opportunità, sono tutto ciò che un uomo non può affrontare.
Lo puoi trovare qui:
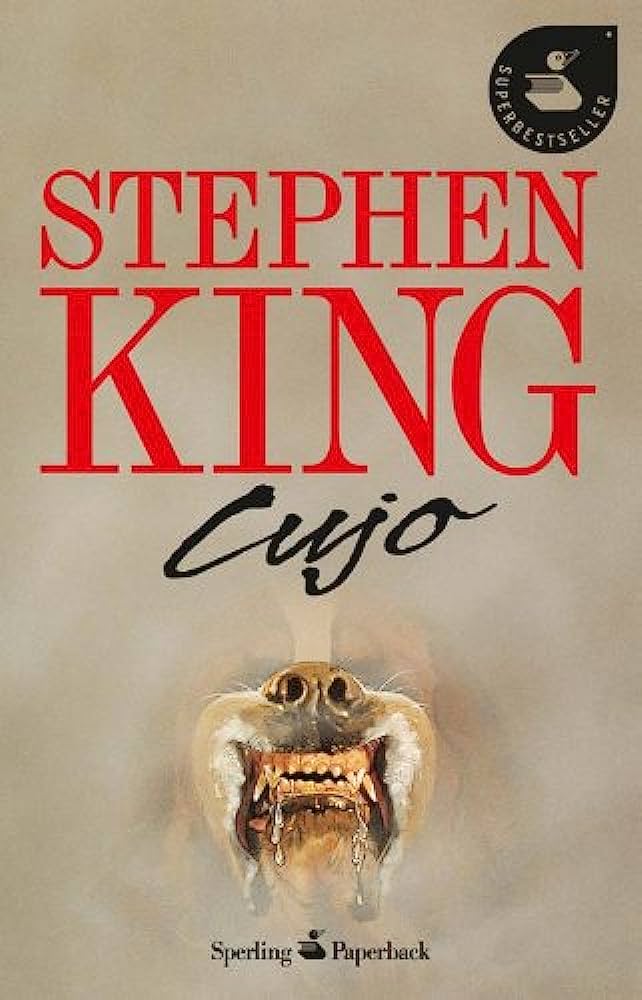
“Il cane che era cresciuto con lui, il cane che aveva pazientemente trascinato in giro per l’aia un bambinetto urlante di gioia sulla sua macchinina a pedali, imprigionato dalla bardatura che gli aveva costruito Joe in officina, il cane che aspettava ogni pomeriggio pazientemente vicino alla cassetta delle lettere l’arrivo dell’autobus della scuola, con il bello e il brutto tempo… quel cane era solo un vago ricordo a confronto di quell’apparizione che lentamente si andava materializzando nella nebbia del mattino.”
È questo il destino delle cose belle, a Castle Rock: trasformarsi in qualcosa d’altro, trasformarsi in vaghi ricordi che sono felici solo nella memoria. Come un matrimonio che viene corrotto dalla lordura di un tradimento. Come un’avventura professionale che naufraga nel sangue di un prodotto chimico sbagliato. Come una famiglia che si perde nelle violenze quotidiane, nel rancore, nel desiderio di qualcosa di diverso, nell’impossibilità di lottare per quello che si ha quando l’orrore te lo porta via per sempre. Come quel mostro impalpabile che aspetta il suo momento tra i vestiti e i giocattoli di un armadio nella camera di un bambino.
Cujo, l’enorme San Bernardo della famiglia Camber, incarna l’anima oscura di Castle Rock. È rappresentazione fisica delle anime che vanno alla deriva quando i piccoli sbagli quotidiani si moltiplicano trasformando ciò che era bello in qualcosa di diverso, in un ‘altro’ che appare incomprensibile solo perché si sono persi i pezzi del puzzle che lo compongono.
Castle Rock, una Derry ante-litteram, un luogo che nasconde orrori ai quali però, in qualche maniera, gli esseri umani tentano di opporsi. Orrori più sottili, meno potenti e ancestrali di IT. Orrori contro i quali, in qualche modo, è possibile combattere.
Lo stesso Cujo, nella sua metamorfosi catalizzata dalla rabbia trasmessagli da un pipistrello, tenta di aggrapparsi ai suoi ricordi. Prova a ribellarsi ma non può vincere. La degenerazione patologica cui è sottoposto, la distruzione del suo cervello per mano del virus, assomiglia pericolosamente allo schianto di una mente umana quando il dolore, l’egoismo, la cattiveria, il narcisismo o anche semplicemente la paura prendono il sopravvento.
Guarire dalla malattia – per qualcuno – è possibile. Ma restano cicatrici, ferite profonde. Resta l’impressione di aver fatto qualcosa per meritarsi l’orrore, resta la convinzione di non aver fatto abbastanza per combatterlo. Resta soprattutto l’inquietante consapevolezza di non essere innocenti: perché se per Cujo la rabbia e la degenerazione non sono mai state una scelta ma il susseguirsi di un domino sfortunato di eventi, per gli altri, per Vic, Donna, Charity, Joe, per tutti gli altri, per noi, si può dire lo stesso?
Cujo non è un romanzo perfetto, per più di un motivo. Eppure le sue pagine sono intrise di una ferocia appariscente e sanguinaria, quella di Cujo, che però si rivela essere poca cosa rispetto al senso di perdita misto a speranza che ci resta incollato addosso. Rispetto alla consapevolezza di una coscienza oscura strisciante, in agguato, pronta a infestarci e a sfruttare i nostri più piccoli errori con il solo scopo di fare del male.
Lo puoi trovare qui:
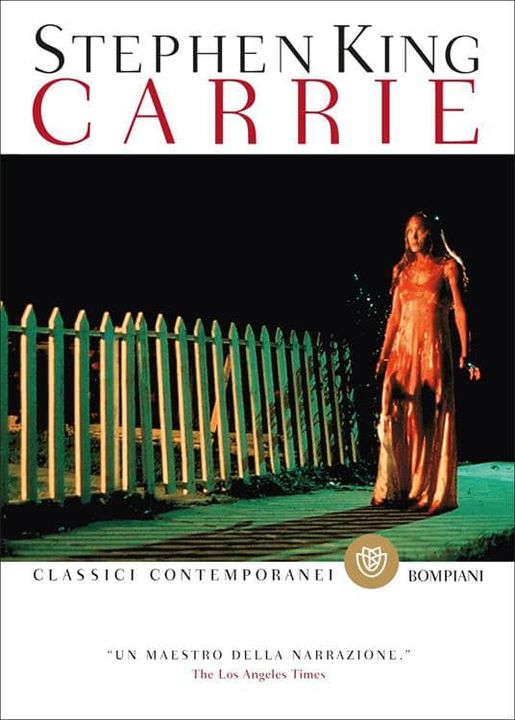
“Ma il “mi dispiace” è il pronto soccorso delle emozioni umane. È quello che dici quando rovesci una tazza di caffè, o mandi fuori pista una boccia quando giochi a bowling. Il vero dolore è raro come il vero amore.”
Tutti abbiamo conosciuto una Carrie White nella nostra vita.
Tutti, da bambini, abbiamo preso parte all’inesorabile danza di cattiveria sulla cui pista si trovano a ballare vittime involontarie. Inconsapevoli.
Alcuni, forse i più fortunati di noi, qualche volta, si sono sentiti come Carrie White.
Hanno subito la violenza di un ballo al quale non si vuole partecipare, la solitudine inflitta alla diversità quando si è troppo giovani, o troppo stupidi, per volerla comprendere. O per provare almeno a capirla.
C’è molto del King che verrà, in Carrie. Ci sono indizi, situazioni, riflessi e riferimenti.
C’è una struttura narrativa che precorre i tempi confezionando una sorta di mokumentary ante-litteram, mescolando realtà e teoria. Errori e possibilità.
“Fu una sensazione terrificante. La mente e il sistema nervoso di Sue erano diventati come una biblioteca: e qualcuno con urgenza disperata correva in mezzo a lei, con le dita che sfioravano di sfuggita gli scaffali dei libri, togliendone qualcuno, scorrendolo in fretta, rimettendolo via, lasciandone cadere altri, con le pagine che svolazzavano selvaggiamente”
C’è anche la volontà di mettere e mettersi a nudo. C’è la necessità della comprensione, il coraggio che questa comporta, l’orrore derivato dalla sua assenza.
Un orrore figlio di sbagli che si sommano a sbagli. Errori che si elevano a potenza trasformando quelle che potrebbero essere tante casualità involontarie in un’unica, collettiva, imperdonabile colpa.
Lo puoi trovare qui:
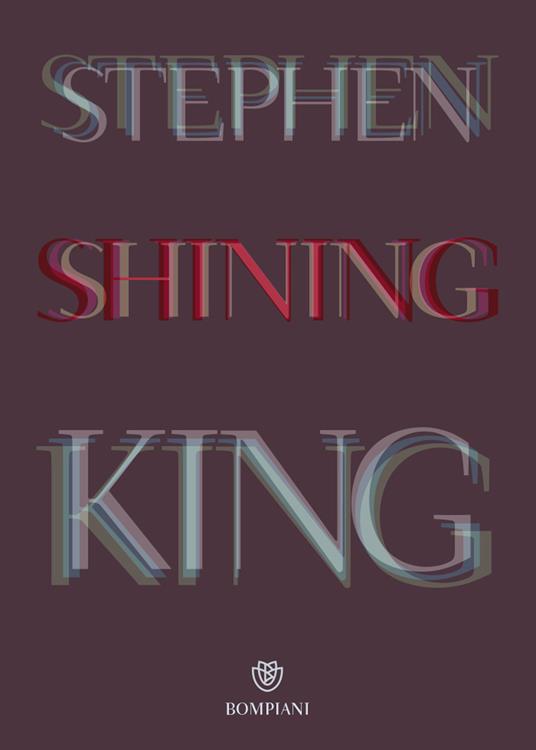
Shining – Stephen King – Bompiani
“All’Overlook tutte le cose sembravano animate da una sorta di vita propria. Era come se l’intero edificio fosse stato caricato con una chiave d’argento. L’orologio marciava. L’orologio marciava.”
Doc. Wendy. Jack. L’Overlook Hotel, per la famiglia Torrance, è l’ultima possibilità. Lo è per Jack, insegnante alcolizzato con il sogno di diventare scrittore. Lo é per Wendy che vive nelle (e delle) speranze del marito. Che lo ama ma che ha paura di quello che potrebbe diventare. Lo è, sopratutto, per Danny “Doc”. Perché sei anni sono troppo pochi per affrontare il DIVORZIO e sono pochi anche per sconfiggere da solo la Brutta Cosa che infesta i pensieri di Jack.
Perciò l’Overlook Hotel, un enorme albergo incastrato tra le montagne, e il lavoro da custode sono il luogo e l’occasione ideale per la rinascita della famiglia Torrance. I mesi invernali insieme, soli, lontani da tutto e da tutti. Lontani dalla Brutta Cosa, con il tempo per scrivere, per rigenerarsi. Per archiviare del tutto lo spettro del DIVORZIO.
A meno che.
A meno che l’Overlook Hotel non sia solo un semplice albergo. A meno che la strana perspicacia di Doc e il suo sapere le cose, siano solo alcuni dei sintomi di qualcosa di più complesso. Di più articolato. Di più potente. Di più desiderabile.
Stephen King racconta di una famiglia. Racconta della lenta e inesorabile autodistruzione di Jack. Un fratturarsi un pezzo alla volta fino alla contemplazione assoluta del fallimento. Racconta di come Doc debba diventare uomo, in fretta e nel modo peggiore. Di come debba imparare che “Il mondo è duro, Danny. Se ne frega. Non ci odia, no, ma nemmeno ci ama”. Racconta di come Wendy sia costretta a fare i conti con i suoi retaggi, le sue debolezze. Il suo dover essere più di quanto è stata fino a quel momento.
Ma sopratutto racconta dell’Overlook Hotel. Tutte le parole che sgorgano dalla penna di King tessono una ragnatela di eventi, di situazioni, di intenti, di possibilità, di rischi e di morti che si ha come baricentro proprio l’Overlook Hotel.
King ci lascia intuire con largo anticipo cosa succederà alla famiglia Torrance e all’Overlook stesso: non gli interessa e non vuole stupirci. Non vuole avere questo tipo di segreti con noi.
Perché King vuole raccontare dell’Overlook Hotel. Vuole che ci ossessioni, proprio come ossessiona Jack. Vuole che ci spaventi, proprio come spaventa Doc e Wendy. Vuole farci capire che ci sono luoghi che hanno raccolto troppe cose, che hanno visto troppe vite brillare e troppe anime consumarsi tra le loro pareti. E che per questo vogliono creare le loro cose, vogliono brillare e vogliono consumare (e consumarsi). Luoghi che hanno bisogno di un potere come quello di Doc per essere più di quanto sono stati fino a quel momento.
Ed è esattamente questo, che fa. Sacrificando alcune cose e lasciando che l’aura dell’Overlook – il suo Shining – divori tutto il resto. Con la stessa voracità delle fiamme.
Lo puoi trovare qui:
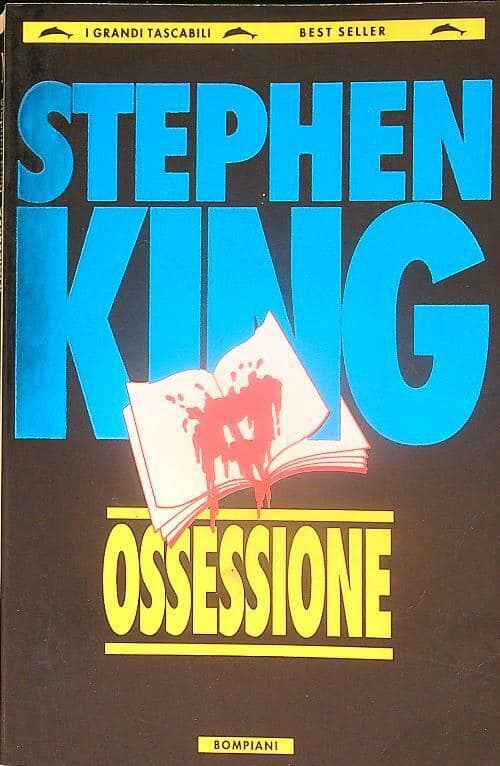
“Quando hai cinque anni e ti fai male, lo fai sapere a tutto il mondo. A dieci ti limiti a piagnucolare. Ora che arrivi a quindici hai già cominciato a mangiare le mele avvelenate che crescono sul tuo interiore albero del dolore. E questa l’Edificazione secondo la filosofia occidentale. Cominci a ficcarti il pugno il bocca per soffocare le urla. Sanguini solo dentro.”
Charlie ha diciassette anni. È solo, Charlie. Combatte contro i ricordi che troppo spesso diventano demoni e lo tormentano. Combatte contro un dolore che non riesce più a tenere dentro di sé, un dolore antico che che arriva da lontano perché il padre
“Forse si era dimenticato o non aveva mai saputo che i bambini crescono ricordando ogni schiaffo e ogni parola di disprezzo, che crescono con la voglia di mangiarsi vivi il loro padre.”
Sceglie la strada peggiore, Charlie. Un sentiero che percorre un passo dopo l’altro fino a quando impugna la pistola e uccide due dei suoi insegnati e prende in ostaggio tutti i suoi compagni di classe. Lì Charlie inizia il suo esperimento sociale di cui lui stesso è la prima cavia. Ossessione – Rage, rabbia, nel titolo originale – è il primo romanzo di King firmato con lo pseudonimo di Richard Bachman.
È un romanzo che, pubblicato 22 anni prima della strage scolastica di Columbine, potrebbe facilmente vestire i panni di una macabra profezia americana. Ma, in realtà, è un romanzo che destruttura la società per come la conosciamo richiamando quello che William Golding raccontava ne Il signore delle mosche: un ecosistema dal quale gli adulti vengono rimossi. Una nuova struttura sociale nella quale per una mattina intera puoi smettere di sanguinare solo dentro e permetterti, per una volta, di lasciare che il dolore scivoli fuori dalla morsa dei denti.
Gli adulti sono rimossi da questa narrazione. Sono inconsapevoli ostacoli che la follia di Charlie allontana nel peggiore dei modi. Nella mente di Charlie sono ecosistemi troppo diversi che impediscono agli adolescenti di svilupparsi come dovrebbero. Che li controllano, li inibiscono e, di fatto, li trasformano in adulti crudeli, sciatti, cattivi.
Questo è l’esperimento di Charlie: lasciare che per poche ore i ragazzi (ri)scoprano i pericoli, gli orrori e la voracità di una crescita senza inibizione.
Ossessione non è un romanzo perfetto ma è lucido nell’orrore che racconta. È cinico nel ricordarci che se il mondo degli adulti e quello dei ragazzi non trovano punti di contatto, rischia di essere la follia a crearli. Perché
“La follia è quando non riesci più a distinguere le cuciture che tengono insieme il mondo.”
e senza quelle cuciture non è solo il mondo a cadere a pezzi. Sono tutte le regole, le connessioni e i compromessi che ci permettono di diventare adulti migliori.


