Se uno di questi commenti dovesse convincerti alla lettura, fammelo sapere. E soprattutto fammi sapere se quello che ti ho consigliato ti è piaciuto.
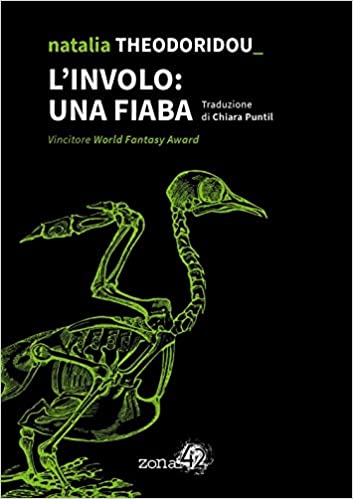
L’evoluzione è complessità? L’involuzione è semplificazione? Forse. O forse no.
Perché quando la terra viene colpita da un virus inarrestabile che involve tutti gli essere umani a volatili delle più svariate specie, quando le scuole diventano gabbie per rondini, quando la Grecia si trasforma in una landa diroccata dal virus, per Maria e per la figlia che porta in grembo c’è solo un modo per sopravvivere.
La favola. Una favola che Maria tesse e disfa, come una novella Penelope, in cerca dell’intreccio giusto, del giusto finale.
E allora l’involuzione non è più semplificazione, la favola non è più un modo per districare la complessità ma diventa l’unica via da percorrere per accettare l’epidemia, la perdita e per coltivare la speranza.
Natalia Theodoridou fa esattamente questo. Nel suo racconto lungo “L’involo: una fiaba” destruttura l’inaccettabile presente pandemico di Maria ricordandoci perché nelle favole è nascosta la chiave per decifrare una complessità altrimenti impossibile da spiegare.
E lo fa attraverso due (tre?) donne coraggiose, le loro perdite e le loro speranze offrendo anche una nuova coordinata per ciò che crediamo essere la libertà.
Lo puoi trovare qui:

La fantascienza può essere (ed è) molte cose. È futuro, è presente, è passato e per questo è memoria.E la memoria ha tanti volti. C’è quella legata ai ricordi, c’è quella legate ai luoghi, c’è la memoria genetica e c’è la memoria evolutiva. Daryl Gregory in questo suo racconto lungo intreccia queste differenti memorie per indicarci un sentiero. Un sentiero di vita, di sopravvivenza e di speranza. Un sentiero da percorrere in nove giorni lunghi quasi novant’anni che conduce attraverso un mondo complesso e complicato dove evolversi è sopravvivere. Ma dove evolversi è anche, e soprattutto, vivere. E non in contrapposizione all’invasione aliena in corso, ma in qualche modo insieme a essa. Gregory celebra la straordinaria normalità delle emozioni che non possono, e non devono, cedere il passo alla sopravvivenza. Lo fa con un tratto morbido che riesce a rendere affilato rivolgendosi, a volte, a una fantascienza più classica. Evolvere è ricordare perché sono i ricordi, quelli più forti e importanti, a catalizzare il cambiamento. E sono quei ricordi, in una sorta di darwinismo emotivo, a determinare cosa porteremo con noi per sempre.
Lo puoi trovare qui:
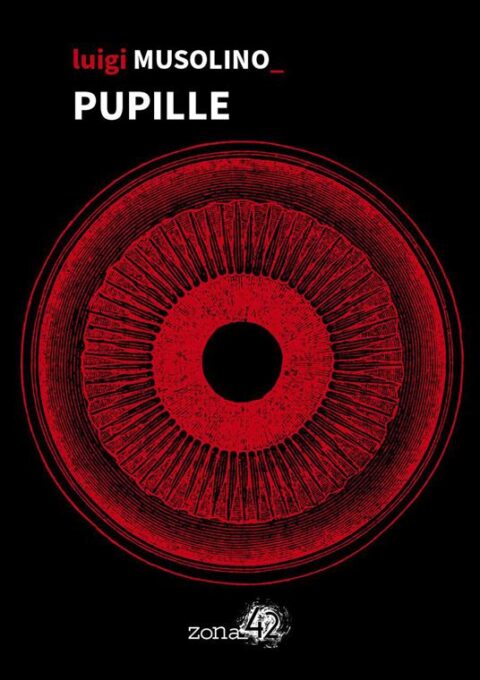
Gli adulti non dovrebbero ficcare il naso nelle faccende dei bambini. Non dovrebbero farlo perché la grammatica dell’infanzia ha regole tutte sue. È cinica, è adattabile, ama il presente, si interessa poco del passato e ascolta il futuro con lo orecchie di chi assapora una fiaba.
Questa è il monito di Musolino e del suo Pupille. Che il mondo dei bambini è troppo spietato perché gli adulti possano sopportarlo, perché siano capaci di decifrarne le coordinate, di comprenderne la portata. E così a Idrasca, paese piemontese ammaccato dalla vita, nido di un uomo nero che si nasconde tra le viscere della scuola elementare, il cammino degli adulti si interseca con quello dei figli, l’esistenza dell’uomo nero svelata. Così Sofia Ratti esplora gli incubi della figlia Beatrice e accatasta i sussurri futuri dell’uomo di polvere sopra le difficoltà di una vita normale e solo un poco più sfortunata delle altre.
Ma se i bambini possono fare i conti con i mostri delle favole, se la loro sintassi li rende capaci di sorreggere il peso di un futuro Nero e disperato, non è così per gli adulti. Il mondo degli adulti vuole risposte, vuole cause e vuole effetti. Il mondo degli adulti non può sopportare lo sguardo del tempo, delle pupille, di migliaia di occhi che sanno e che, più di ogni altra cosa, raccontano.
Musolino in Pupille tesse i fili di una fiaba nera, oscura, che attinge dal passato, minaccia il futuro è trasforma la provincia piemontese dell’autore in un laboratorio nero dove il mondo dei bambini e quello degli adulti fanno quello che non dovrebbero: si intersecano, in un macabro “E vissero tutti felici e contenti”.
Lo puoi trovare qui:
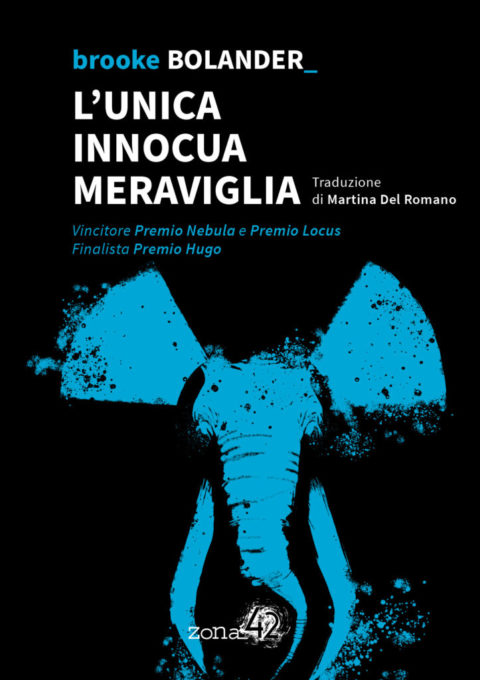
“Non importa ciò che fai, passano quaranta o cinquanta o cento anni e tutto diventa un filo narrativo con cui giocare: così i maestri dell’alchimia mediatica scindono i nuclei della verità che si ripercuotono in una reazione a catena di realtà altamente divergenti.” Broole Bolander
L’essenza della memoria, o della mancanza di memoria, o della distorsione della memoria è l’ecosistema sul quale si sviluppa la favola nera (e anche troppo terrena) raccontata da Brooke Bolander ne “L’unica innocua meraviglia”. L’autrice affonda le mani nello stereotipo che vuole gli elefanti come portatori di una memoria impossibile da cancellare, che si propaga e si trasmette, ancestrale, attraverso il tempo e persino attraverso le specie. Le immerge nelle leggende e nella tribalità di una specie associata al pericolo nucleare (meravigliosa l’immagine di copertina) ed estrae la materia prima, un fango mistico e cinico, con il quale modella il suo racconto. Così Regan, umana che vive nel presente perché il futuro gli è stato tolto, rappresenta la mancanza di quella memoria che rende gli elefanti portatori di Storie. Così Topsy, allontanata dal branco, dalle Madri, dall’eredità mentale di una razza che fa dei racconti una religione ancestrale, rappresenta un richiamo a cui è impossibile resistere. Così l’unione tra le due, tra Regan e Topsy, tra la rabbia e la memoria, tra la memoria e la vendetta, catalizza una nuova essenza. Una forma nuova e nobile, pronta a essere però mistificata dalla cronica, cinica, voluta e tossica mancanza di memoria dell’uomo. Pronta però a essere ricordata dalla devozione della Madri, degli elefanti, alla verità. La storia di Brooke Bolander è romantica e spietata. È rabbiosa e nitida. Raccoglie le storture nel presente e le nasconde in un futuro nel quale qualcuno – e non può essere l’uomo – deve ricordare la verità.
Lo puoi trovare qui:
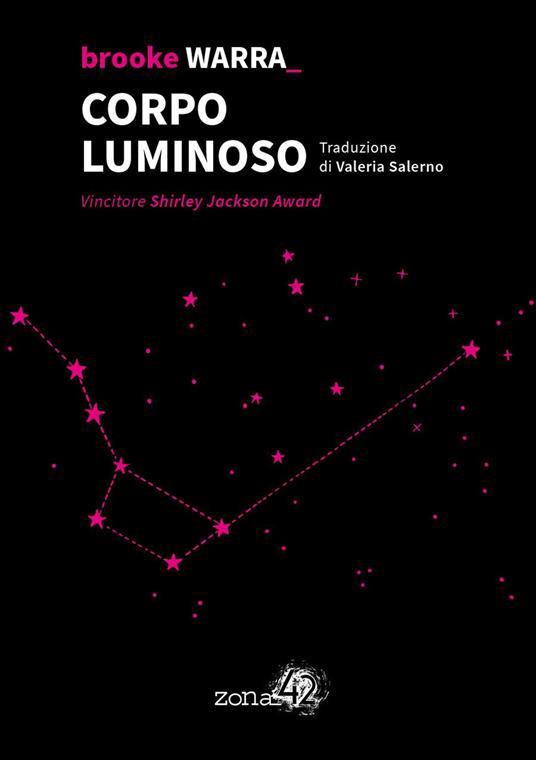
“Ho preso la forma di ogni incontro.”
Ecco la consapevolezza che Mo ha di sé. Una consapevolezza che nemmeno lei comprende fino in fondo, un’eredità che la accompagna da sempre. Da quanto il padre l’ha abbandonata. Da quando sua madre se ne è andata. Da quanto accanto a lei è rimasta solo nonna Gertie, solida ancora senza tempo di una generazione di donne combattenti che hanno sempre trovato la loro strada. In un modo o nell’altro. Giusta o sbagliata.
Mo ha preso la forma del dolore senza saperlo, ha preso la forma di relazioni sbandate, di amicizie dimenticate, di incontri strani dagli esiti ancora più strani. Ha preso la forma degli altri o meglio ha cambiato la propria forma cercando di farla aderire, in qualche maniera, a una realtà che le ha fatto scivolare addosso gli anni.
Perciò è arrabbiata, Mo. È furiosa e indipendente e cerca con tutte le forze di ritrovare – o di scoprire per la prima volta – quale è davvero la sua, di forma.
Brooke Warra si presenta a questo appuntamento affilando la scrittura fino a farla diventare un’arma. Un’arma nelle sue mani, in quelle di Mo, un’arma che la protagonista di ‘Corpo Luminoso’ sventola per difendersi, per ferire – per ferirci -, per attaccare. Un’arma che finisce per rivolgere contro sé stessa quando uno degli ultimi incontri della sua vita la mette a nudo, indifesa, ma al tempo stesso capace di lottare come non hai mai fatto nella vita.
Quella di Brooke Warra non è un favola. È una storia di rinascita, di consapevolezza, di dolore, di abbandono, di solitudine, di scelte sbagliate, di decisioni giuste, di accettazione e di resa.
È un vortice che scorre sempre più veloce, che definisce nuove cartografie umane: mappe emotive e stellari che orbitano tutte intorno a un nuovo “Corpo luminoso”.
Lo puoi trovare qui:

“Nella fuga dalla spada e dal fuoco della guerra nacque Osupa”
Sono queste le parole con cui Dare Segun Falowo ci apre le porte del villaggio di Osupa. Un villaggio nato dalla magia popolare, dalla saggezza e dalle credenze di un popolo di rifugiati che cerca nella tradizione una nuova via per la rinascita. “Convergenza nell’architettura del coro” non è un testo facile come non è mai facile entrare, anche se invitati, tra le millenarie tribalità di una cultura. Tra le ombre e le luci dì mitologie che affondano le loro radici nel ventre della Terra e che sognano (o vedono come un incubo) il futuro rivolgendosi alle stelle. Ed è proprio questo che Falowo ci offre.
Un viaggio nel passato e nel futuro, nella terra e nello spazio. Un viaggio disinvolto nella sua complessità, magnetico nel suo essere a volte difficile da seguire. Ma è anche questa la sua bellezza: la sincerità. Una sincerità di intenti, senza compromessi. La sincerità dì chi espone le speranze e la paure dì un popolo, la voglia dì riscatto, il desiderio misto a timore dì poter essere più di ciò che si è. Aggiungo: un’occasione preziosa per imparare e per conoscere. Per cambiare prospettiva. Unica avvertenza: aprirsi completamente senza la pretesa o l’obbligo dì capire come siamo abituati a fare. Ma assorbire tutto ciò che l’autore ci offre.
Lo puoi trovare qui:

“A volte le fondamenta su cui poggia la nostra vita si inclinano e tutto quello in cui credevamo prima, a cui eravamo affezionati, comincia a scivolare via, e di colpo ogni cosa sembra nuova e strana.”
Ghoul accovacciato numero otto di George Saunders è anche questo. Un bizzarro piano inclinato che ci appare lontano, surreale. Un piano dapprima congelato nel mantenimento di uno status quo quasi alieno, tutto lettere maiuscole e stranezze. Un ecosistema che orbita intorno ai Visitatori e alla replica di un funesto parco dei divertimenti all’interno del quale i ruoli da figurante si mescolano con le ambizioni, i dolori e le speranze della vita.Poi il piano si inclina e Brian, il protagonista, inizia la sua lenta ma inesorabile scivolata. Uno scorrere fatto di lettere, di sincerità, di paure e di consapevolezze. Uno scorrere nel quale a poco a poco – con terrore e sorpresa crescente – finiamo con il riconoscerci. Perché? Perché l’autore smette i panni del narratore e indossa quelli uno specchio deformante che però restituisce comunque ciò che ha davanti. Come l’amore che a un certo punto si intromette nella vita di Brian. Un amore strano, catalizzato dal profondamente sbagliato, dalle storture della vita nel parco divertimenti.
“Dovrei sentirmi in colpa, immagino, perché tu pure hai fatto qualcosa di male, e non sei ancora stato punito, – dice. – Cavolo. E adesso sto facendo qualcosa di male, e un domani potrei essere punita. Solo che con te non mi interessa più cosa è giusto o sbagliato.”
Dice Amy. Perché lí, nel mondo dei ghoul accovacciati, l’unica arma è la sincerità. Un sincerità scritta, mai detta, perché nelle parole dette si nascondono le cose storte. E se tutto intorno ci sono bugie, se tutto intorno ci sono cose giuste che però in realtà sono sbagliate, l’unica cosa da fare è lasciare che il piano si inclini. E correre, e rotolare, insieme a chi rende il giusto e lo sbagliato poco meno che punti di vista.
Perché la verità, alla fine, è un prigione.
Lo puoi trovare qui:

“Il corpo di suo padre era solo troppo piccolo per tutto il mondo che entrava nella sua testa”
È piccolo Mitja, e sono piccole Eco e Clio. E il mondo intorno, compresso dalle pareti della casa dei potenziali, è troppo piccolo e troppo grande insieme.
Perciò scappano, Mitja, Eco e Clio. Scappano inseguendo le tracce di una favola di libertà. Scappano cercando di liberarsi da una predestinazione matematica che vorrebbe scrivere il futuro contaminando il presente. Ammaccandolo, ferendolo, facendo sentire loro che sono sbagli, inciampi, errori.
E che i meccanismi dei grandi, della responsabile Matilda e di tutto quello che ci sta intorno sono profezie dalle quali non si può sfuggire.
Eppure Mitja, Eco e Clio scappano. Scappano accompagnati dalle visioni di Mitja, a volte fin troppo reali, scappano sui passi leggeri di Eco, scappano scortati dal silenzio di Clio e dalla muta voce sensibile della tartaruga Maizo.
“E io e Clio lo sappiamo, sì, lo sappiamo che ogni infanzia, ogni adolescenza, ogni vita è in fondo solitaria, silenziosa e terribile”
Lo sanno. Come lo sappiamo tutti noi. Ma sanno anche che nella fuga da ciò che gli altri hanno deciso per loro (per noi?) si nascondono sorprese. Si nascondono semplici meraviglie. Si nascondono libertà che non riusciamo a comprendere fino a quando non le stringiamo tra le mani.
Maizo è una favola, e un incubo, e un sogno e una realtà. La realtà di voler essere. Sempre. A qualunque costo. La realtà delle nostre cicatrici, cerotti che tengono insieme gioia e dolore.
Lo puoi trovare qui:

“L’ultima volta che Ben e Lois Devine videro Veronica Glass, la nota artista delle mutilazioni, fu a una festa suicida a Cerulean Cliffs, una colonia di artisti ben al di là delle loro possibilità”
Inizia così. Inizia esponendomi alla cinica ironia delle divinità letterarie che a gennaio del 2000 avevano piazzato sul mio sentiero di lettore Cecità, e che oggi si prendono gioco di me offrendomi “La fine della fine di ogni cosa”. Cosa ho trovato tra le pagine di questo racconto?
Ci sono degli artisti. C’è una villa in riva al mare, aggrappata alle rocce di una scogliera. Ci sono delle feste e tutto intorno “la rovina”. Un male indefinito e indefinibile che sta piano piano rosicchiando ogni cosa. Divora luci. Divora la vita. Trasforma tutto in polvere spazzando via l’eredità materiale dell’uomo.
Tra le città distrutte, tra le onde di un mare reso grigio e morto, tra i prati aridi che Dale Bailey racconta ha risuonato nella mia testa una poesia scritta in un altro luogo e in un altro tempo, l’Ozymandias di Percy Bysshe Shelley.
“Null’altro rimane. Intorno alle rovine
Di quel rudere colossale, spoglie e sterminate,
Le piatte sabbie solitarie si estendono oltre confine”
Perché? Forse perché quella parola, ‘rovine’, che tanto bene si sposa alla fine delle cose di Bailey. O forse – soprattutto – perché Ben Levine è un poeta. È un poeta che odia e ama la sua arte. Odia e ama la semplicità delle cose che possiede, odia e ama la lussuria di ciò che potrebbe avere e che non ha. O non vuole. O che ha senza volerle davvero. Nella villa alla fine delle cose si ritrovano artisti. Artisti che dovrebbero conoscere il mondo, che dovrebbero averlo esplorato nelle sue parti più nascoste e che proprio per questo, in qualche maniera, dovrebbero resistere più di tutti alla “rovina”. È forse quello, in realtà, il senso delle feste suicida? Un ultimo fronte di resistenza, una sorta di legge del più forte, un tentativo non tanto di sopravvivere quando di morire per ultimi?
“L’arte per l’arte”
È il mantra di Veronica Glass. Opaco personaggio che sembra aver danzato sulla fine del mondo prima che il mondo iniziasse davvero a finire. Veronica Glass è tutto ciò che Ben vuole e tutto ciò di cui ha paura. È la risposta alle domande che non vengono fatte. È a suo modo l’inizio e la fine della rovina, ma di una rovina persino più profonda di quella fisica che Ben e gli altri affrontano. Una rovina morale. Una resa all’arte per l’arte.
“Perché c’è bellezza nel dolore e nella nostra capacità, nel nostro coraggio, di sopportarlo”
Eppure. Eppure Bailey riesce a distillare speranza. A riportare la bellezza al centro. Nel caleidoscopio di morte e dolore e sofferenza e resa e nichilismo che Veronica Glass incarna e in cui tutti gli altri guardano, Bailey riesce a dare colore alla rovina. Riesce a raccontare che la bellezza perdura anche se non c’è più nessuno a guardarla.
Oggi, più che in altri momenti, ne avevo bisogno.
Lo puoi trovare qui:
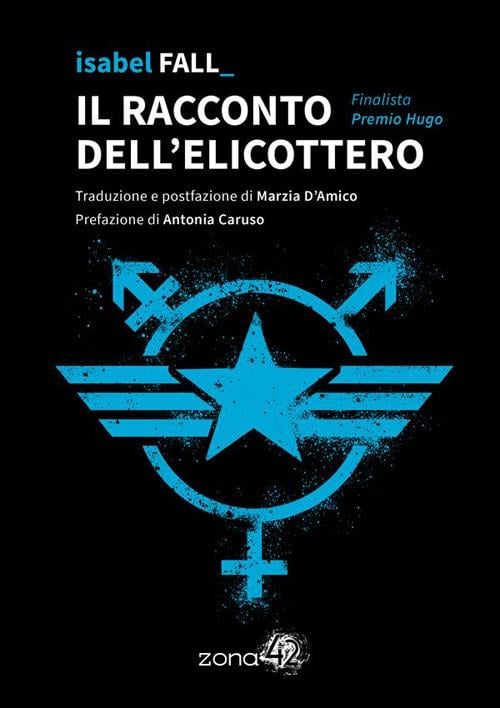
“Mi identifico sessualmente come elicottero d’attacco”
Ecco l’incipit de “Il racconto dell’elicottero”. Una frase che al suo interno racchiude tutta la stranezza di questo racconto di Isabel Fall. Perché “Il racconto dell’elicottero” È un’opera strana, senza ombra di dubbio. Un’opera di certo sperimentale, di certo un’opera di rottura e che proprio per questo si presta a un test: provate a leggere la bella prefazione di Antonia Caruso DOPO aver letto il racconto. Io ho fatto così, per caso. Ma credo sia stata una buona idea. Credo che abbia reso giustizia al disordine controllato con il quale la Fall ha imbevuto le pagine.
“Le ragioni della guerra non contano molto per noi. Vogliamo combattere così come una donna vuole essere graziosa, come un uomo vuole essere deciso. Il nostro bisogno è ostentato come una regina impettita […]”
Nessun dubbio. Questo È un racconto di guerra. La guerra ne fa parte. Ne permea ogni parola e avvolge come un sudario di determinazione Barb., protagonista del lungo volo dell’elicottero. Ma è anche un racconto di rabbia. Di collera gridata e di perdono sussurrato. Di difficoltà di comprensione, di nichilismo, di predestinazione e ribellione. Picchia duro, Isabel Fall. Picchia talmente duro che più di una volta inciampiamo nelle sue scuse, dirette proprio a noi che leggiamo. Scuse, forse, più di circostanza che di necessità.
“Così, nello stesso modo in cui abbiamo legato suoni e significati per creare il linguaggio, abbiamo iniziato a legare cluster di comportamenti per indicare i ruoli sociali. Questi cluster erano ricchi, in rapida evoluzione e quindi, proprio come per il linguaggio, avevamo bisogno di reti dedicate alla loro elaborazione.”
Di nuovo, nessun dubbio. “Il racconto dell’elicottero” è anche una storia di linguaggi che non si adattano, di fraintesi, di necessità. E le necessità della Fall sono così forti (lo scoprirete davvero solo leggendo la prefazione e l’altrettanto fondamentale post-fazione di Marzia D’Amico) dal portare la guerra distopica che devasta gli Stati Uniti fuori dalle pagine del racconto. Da far bucare al conflitto la parete letteraria che di solito protegge il lettore dagli orrori, dalle verità e dalle profezie.
Non è un racconto facile. Non lo è. È più un grido, una provocazione, uno stato delle cose. Il prodotto di un contesto che forse – e dico forse – è meglio conoscere solo dopo aver letto la storia di Barb, un elicottero di attacco.
Lo puoi trovare qui:

“Pensò che in tutta una vita a inseguire la musica l’accordo perfetto, il sound definitivo – non si era mai effettivamente chiesto cosa fosse per lui quella strana vibrazione che il nostro cervello trasforma in suono, melodia, parole cacciate fuori con rabbia o sussurrate a quell’ombra che se la nutri troppo si mangia il diaframma, i muscoli, le ossa, e poi tutto il resto attorno.
I giorni passarono, uguali e incolori, e lui non trovò risposta.”
Un’alluvione riporta alla luce misteri e tormenti dimenticati. Vecchi articoli di una rivista musicale, la chimera di un Concerto unico al mondo e la sparizione di un ragazzo che forse si era messo sulle tracce di qualcosa di più grande di lui.
C’è una grande malinconia di fondo in questo romanzo breve. Una ricerca sofferta, un inseguire il tempo passato, un rincorrere un futuro incerto, asettico, spoglio.
C’è l’amore per la musica, per l’arte, per quello che potremmo essere e che non siamo stati.
Ci sono tanti personaggi, forse qualcuno di troppo, personaggi che entrano ed escono dalla storia come le note entrano ed escono da uno spartito.
C’è la voglia di trovare qualcosa di più che un lento sgocciolare di giorni, mesi e anni. Ma c’è anche la consapevolezza che forse questo qualcosa di più non lo possiamo comprendere.
Lorenzo Bianchi, in qualche maniera, si mette a nudo. E forse mette a nudo anche i suoi dubbi tratteggiando una storia che non ha la pretesa di spiegarsi e di spiegarci.
Lo puoi trovare qui:
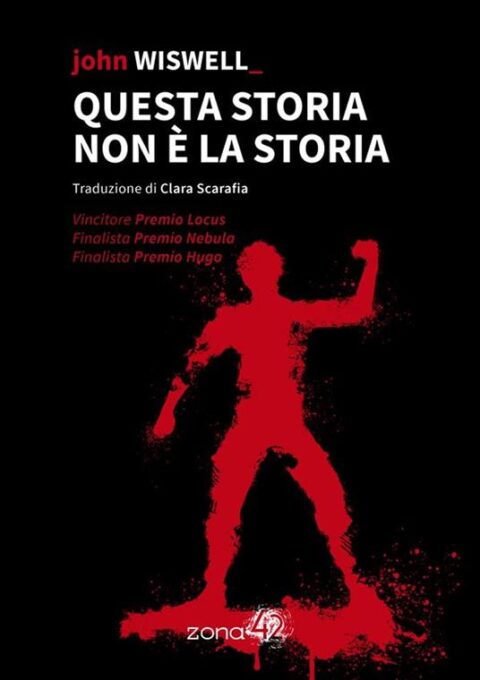
“Anton non l’ha mai aggiustato l’orologio. Ma lo porta via con sé.”
Le cose rotte non si abbandonano, anche quando non si ha la forza di aggiustarle. Delle cose rotte bisogna avere sempre cura perché tutti, prima o poi, ci spezziamo. È così per Anton, famiglio riluttante del vampiro Mr. Bird. Quelle di Anton sono fratture profonde, ferite che hanno messo radici, che si sono allungate fino a raggiungere tutto ciò che rende un essere umano quello che è.
“Loro non capiscono cosa significa sanguinare ogni volta che deludi qualcuno.”
E se Mr. Bird non fosse solo un vampiro? E se la dipendenza di un famiglio dal suo Maestro non fosse solo un fatto di sangue? Se la trappola in cui Anton si è trovato invischiato per anni, la trappola di chi “usava la vaghezza per sembrare onnipotente“, andasse ben oltre le ferite purulente sulle cosce del ragazzo? John Wiswell ci racconta una storia. Una storia di redenzione, di rinascita, di libertà, di debolezza, di forza, dei poteri curativi dell’immaginazione e, soprattutto, una storia di necessità.
La necessità di non aggiustare tutto quello che incontriamo, cose o persone che siano. La necessità di capire che dietro ogni cosa rotta di sono motivi e che ogni cicatrice ha una sua storia. Anche se, a volte: “Questa storia non è la storia che ti racconterò oggi.”
Lo puoi trovare qui:

“So solo che la primavera scorsa, quando le piogge cominciavano a farsi più rade, Elliot è diventato un corvo”
È così, quando Elliot diventa un corvo, che la normalità di Edda inciampa nell’imprevisto e nell’imprevedibile. Era una normalità sbagliata, la sua, sbagliata per quanto fin troppo comune. Una normalità fatta di silenzi, di dubbi, di paure, di rifiuti. Di troppo alcol. Di cose rotte che non si potevano aggiustare perché se anche Edda ed Elliot quello facevano di mestiere – aggiustare cose – tra loro si era rotto qualcosa che non poteva essere riparato. Fino a quando Elliot non diventa un corvo. E da lì in poi, Edda inizia a vedere tutto. Lo capiamo dal quotidiano pieno di dettagli che ci descrive Francesca Mattei. È un mondo ricco, quello di Edda. Pieno di colori, oggetti, sensazioni. Ogni stanza, ogni ambiente, ogni situazione: c’è una curiosità tutta nuova nel racconto che Edda ci fa di sé, di Elliot. Di loro. Come se certe cose le vedesse per la prima volta, anche se a guardarle sono gli stessi occhi di sempre. Soprattutto, è un mondo che non deve più essere riparato, ma costruito. C’è solo una piccola grande ombra in questo nuovo, strano ma salvifico equilibrio. Una piccola grande parola che vorrebbe essere soluzione ma invece diventa problema: perché?
“Quello che dobbiamo chiederci è quanto scegliamo quello che diventiamo.”
Quindi non perché. Non come. Ma quanto. Quanto di ciò che siamo è frutto della nostra scelta? Nei piccoli cambiamenti quotidiani, nei grandi cambiamenti di una vita. E quando si cambia – Edda lo scopre e finalmente lo capisce – tornare indietro non vuol dire essere quelli di prima. E cambiare – cambiare tanto – a volte è l’unico modo per ricostruire cose che non possono più essere aggiustate. “Gli stessi occhi” ci accompagna attraverso una metamorfosi. Letterale, metaforica, esistenziale. Ci mostra il cambiamento attraverso i dettagli. Ci racconta che cercare un perché, a volte, è il modo peggiore per capire. Lo fa attraverso un quotidiano così strano che alla fine ci risulta normale.
Lo puoi trovare qui:
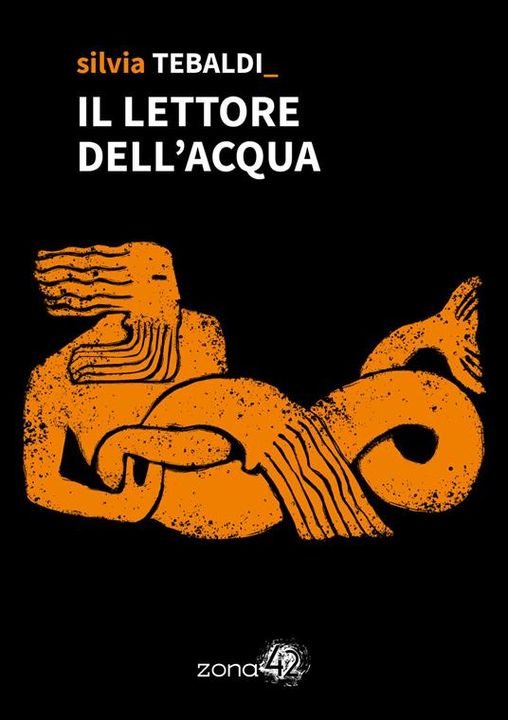
Bologna ha qualcosa che non va. Le cose smettono di funzionare e il Guasto, un’anomalia che non ha colore o spiegazione, a poco a poco si insinua nei giorni di tutti. È agosto, a Bologna. Fa caldo, un caldo terribile, e c’è una strana malattia che colpisce a casaccio. C’è disordine, tutto intorno. E ci sono persone che provano a resistere come possono.
Poi ci sono le domande. Le loro. Le nostre.
E se il Guasto non fosse una causa ma solo LA conseguenza? Se fossero proprio le cose inanimate – ascensori, autobus, treni – le prime a essersi accorte che le persone hanno smesso di comunicare? Se quanto sta accadendo fosse una loro reazione, una loro protesta alla palude di silenzio emotivo che sembra inghiottire i rapporti umani?
Silvia Tebaldi innesca domande. Le inietta nella cornice delicata e onirica di un futuro talmente vicino da apparirci concreto come il passato. Ci offre il punto di vista di Elia, il lettore dell’acqua. Di Mara che combatte, contro la malattia. Di una Bologna che sa che per guarire, prima, deve occuparsi di tutti coloro che la abitano.
Lo puoi trovare qui:
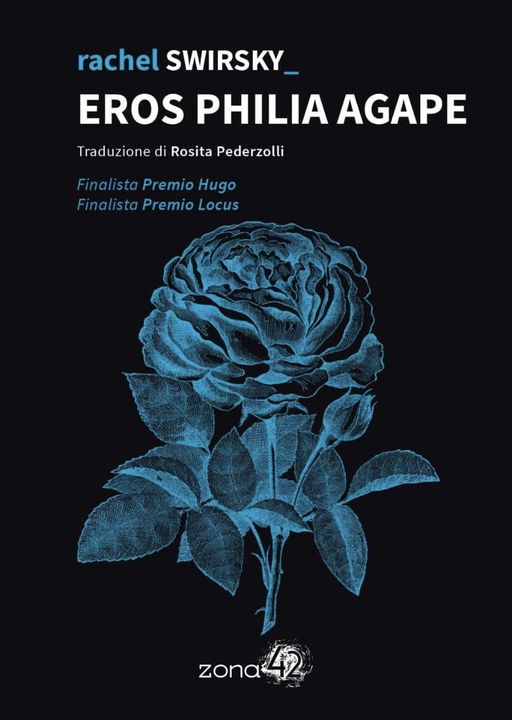
“Lucian amava Adriana come il suo cervello matematico amava la coerenza dell’aritmetica, come il suo cervello d’artista amaca il colore, come il suo cervello di filosofo amava la pietà.”
Amare vuol dire comprendere. Vuol dire ascoltare. Vedere. Conoscere. Ma amare vuol dire anche affrontare sé stessi, guardarsi dentro e scoprire – o cercare – cose delle quali troppo spesso ignoriamo origine ed esistenza.
Questo succede a Lucian, un robot costruito per riempire il vuoto di Adriana, un robot che poi affronta lo sconvolgente viaggio della paternità.
E allora Rose, la piccola Rose, che agli occhi di Lucian non è una bambina ma una persona, diventa uno strano specchio nel quale il robot inizia a specchiarsi. Uno specchio che gli mostra la necessità di sapere cosa si è, di assecondare cosa possiamo diventare.
Rose. Che si chiama come i fiori che coltiva Lucian. Rose. Che non è e non può essere di nessuno perché le persone – come anche le cose – non si possono possedere. Perché il possesso implica la comprensione e la comprensione, a sua volta, non può prescindere da una forma di dolore.
Rachel Swirsky traccia una rotta. Un viaggio. Un percorso incerto, doloroso, necessario. Un tragitto lungo il quale perderemo qualcosa di importante e – se siamo fortunati – impareremo qualcosa di prezioso.
Lo puoi trovare qui:
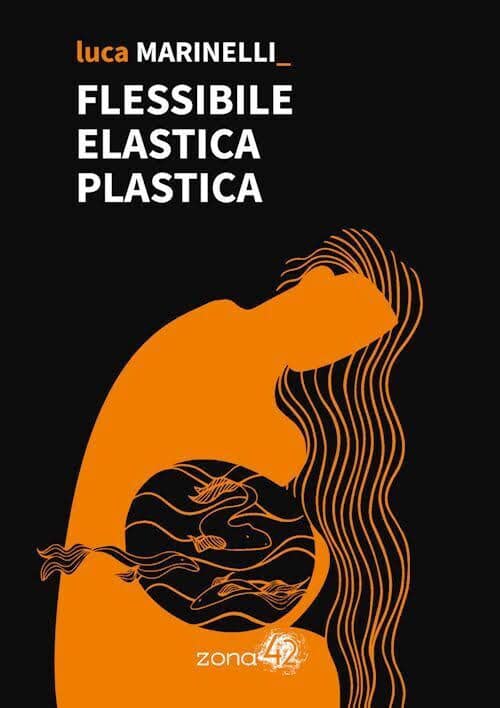
“Il pacco è arrivato una mattina infrasettimanale in cui lui e la sorella erano gli unici in casa.”
In una città senza nome una famiglia senza nome riceve un regalo inaspettato: un cubo bianco capace di assumere ogni forma. Basta chiedere, basta rivolgersi allo strano oggetto e questo assume la forma desiderata.
Il tempo scorre scandito dalle richieste di lui, della sorella, del padre e della madre. Il tempo scorre, inceppato dai malfunzionamenti del cubo. Il tempo scorre fino a quando dal cubo nasce – quasi letteralmente, come fosse un parto – una ragazza completamente bianca, muta.
“È andato in un bar che faceva orario notturno e ha bevuto fino a quando il dolore e il tempo non erano la stessa cosa.”
Luca Marinelli dipinge una tela colorata dalle paure, delle vergogne, dai desideri e delle passioni della famiglia. Scandisce il tempo di lui, di lei, del padre e della madre intrecciandolo con la vita della ragazza bianca. Perché se il cubo incarnava oggetti e desideri materiali, la ragazza ha il potere di diventare riflesso mentale di ciò che la famiglia desidera e teme.
La ragazza é una specchio addestrato dai riflessi di un vita, da ciò che si cerca senza avere il coraggio di cercarlo davvero. Da ciò che si ha e che si perde senza un vero motivo. Da ciò che vorremmo essere senza volerlo mai fino in fondo, immaginando ciò che non siamo.
L’autore fa tutto questo scandendo anche il tempo della nostra lettura, frammentandolo, incatenandolo alla vita di una ragazza bianca che nasce dai desideri di una famiglia e che vede i suoi sfumare.
Come rondini che sanguinano dall’inverno di un amore malato.
Lo puoi trovare qui:

“Ci mettono così poco le cose a decadere, rovinarsi. Non serve usarle troppo, a volte basta usarle troppo poco.”
Vale per tutte le cose. Vale per i sentimenti, per l’infanzia, per il presente e per il futuro. Vale per una casa che diventa scomoda perché troppo piena di ricordi e vale anche per un intero pianeta. Che decade, che si rovina. Perché usato troppo o perché compreso poco. E vale anche per la felicità. Che non si può consumare cercandola a tutti i costi ma che non si può nemmeno ignorare, come se non esistesse.
Questo si trova ad affrontare Caterina mentre lascia la sua casa insieme alla figlia Andrea. Fugge, Caterina. Scappa da un passato le cui cicatrici non si vogliono rimarginare. Scappa da un presente che non vuole meritare. E mentre lei e Andrea scappano, tutto inizia.
E tutto finisce.
Non è solo l’Apocalisse a minacciarle. Non è solo una fine del mondo travestita da terremoti e cataclismi. C’è un intera vita che le rincorre. Una vita usata troppo. O troppo poco.
“Se salvi la vita a qualcuno gli fai una promessa e poi non puoi non mantenerla più.”
Eppure è di promesse che si nutre Caterina. Promesse di dolori mai dimenticati. Promesse di sofferenze a venire. Promesse di ricordi a cui aggrapparsi “quando nulla avrà più importanza”
Così Alessia Principe traccia le geografie del viaggio di Caterina. Un viaggio tra gli orrori fisici di un mondo che sta per spegnersi, un viaggio che diventa insieme fuga e salvezza da tutte quelle cose – usate molto o troppo poco – che hanno spezzato la vita di Caterina incidendole sul ventre il tormento dell’infelicità.
Lo puoi trovare qui:
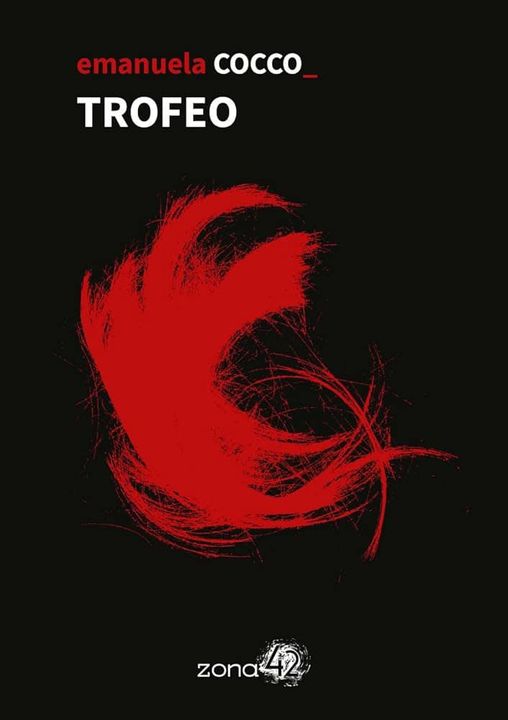
“Le cose che vede sono avviluppate in quelle che lui desidera e immagina, le cose che lui sa sono state sostituite da quelle che lo terrorizzano, le cose che accadono, le cose che contano, continuano a restare fuori dai margini della sua consapevolezza.”
Ci sono cose, in quella casa. Ci sono feticci. Che prima appartenevano a qualcun altro ma che adesso appartengono a Lui. Ci sono trofei. Oggetti di vite spezzate che per qualche motivo conservano i ricordi e le parole delle “loro persone”. Di coloro che li avevano indossati, vissuti. Amati. Sono oggetti spogliati dalle loro vite precedenti che adesso orbitano intorno a Lui, alle sue pulsioni, ai suoi orrori.
E queste cose – questi trofei – imparano le parole. Imparano a pensare, imparano a raccontarsi, imparano a essere. Seppure in modo incompleto. Seppure senza il tempo che servirebbe loro per imparare a sognare.
Ma se quelle cose, quei feticci, quei trofei non fossero solo “cose”? Se fossero le persone che incontriamo di sfuggita, le emozioni che sforiamo, le opportunità che non cogliamo perché ci manca il coraggio per farlo o il tempo per sognare? Se fossero opportunità perdute, smarrite nei corridoi di una vita – la nostra – che ci cannibalizza fino a costringersi in una sola stanza fatta di rancori e di ossessioni?
Emanuela Cocco riduce il tempo, comprime lo spazio. Ci costringe in un cassetto, ci obbliga a mescolare le nostre parole con quelle di altri trofei sconosciuti, rapiti, rubati. Destruttura i nostri desideri e li obbliga a confrontarsi con una rabbia cieca che fingiamo di non conoscere ma che tutti abbiamo sfiorato e che ha imparato a conoscerci, che ha preso qualcosa di noi. Proprio come i trofei hanno assorbito parte della vita di chi li possedeva.
Diventiamo Lui. Senza volerlo. Senza immaginarlo. E senza la possibilità di nessun compromesso. E quando camminiamo tra le stanze deserte della sua (nostra?) vita, capiamo che tutti quei trofei non sono mai stati davvero suoi. Non sono mai stati davvero nostri.
Lo puoi trovare qui:
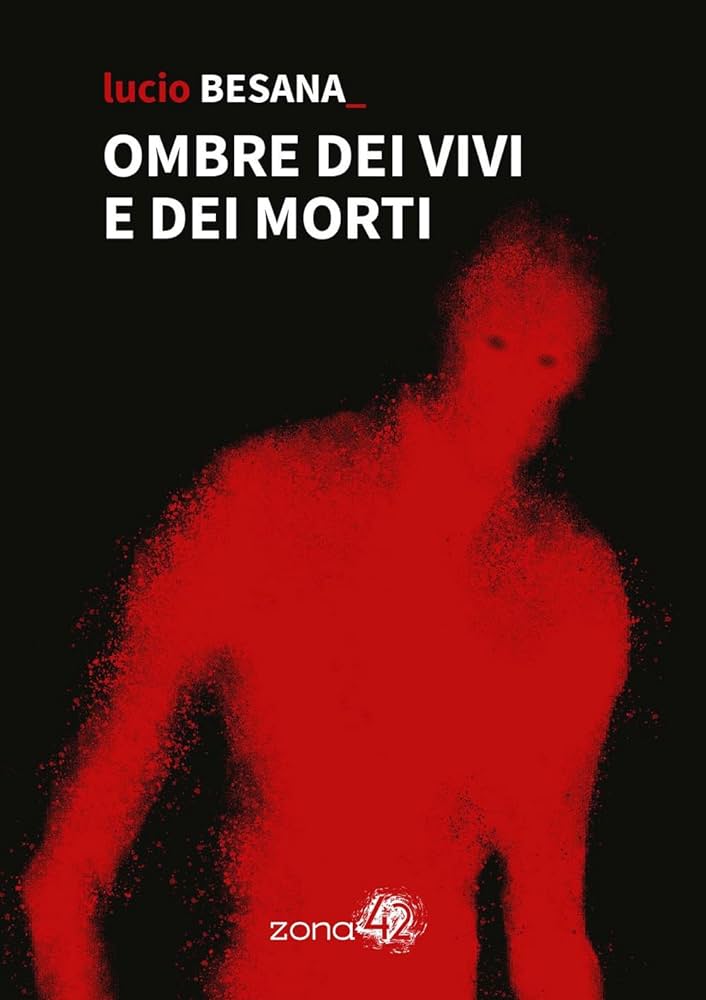
“Non so come i discorsi dell’Osteria fossero giunti alla Storia della Statua; mi sembrava che nella Valle si parlasse una sola conversazione, declinata in una serie di episodi, opinioni e preghiere scaturite da un passato che potevo solo intuire, e per quanto fosse interminabile e affollata, se la ascoltavi abbastanza a lungo avresti udito sempre le stesse parole, sempre le stesse storie.”
C’è una diga, nella Valle. C’è una centrale idroelettrica, e ci sono state la guerre. La prima e l’Ultima. Poi ci sono i minatori che lavorano per la Compagnia, che si tramandano il mestiere di padre in figlio e che ogni tanto muoiono. O scompaiono. Perché la montagna sa essere generosa ma sa essere anche cattiva, bugiarda.
Poi ci sono le Ombre. Che tutti, nella Valle, conoscono. Che tutti accettano. Che qualcuno desidera. E alla fine, ci sono le Storie.
Lucio Besana ci racconta di un posto di frontiera al quale è difficile appartenere ma dal quale è ancora più difficile andare via. Lo fa incidendo sulle pagine e dentro di noi le Storie di chi nella Valle ci vive. Sono Storie strane, quelle della Valle. Raccontate senza rivelarci mai un nome anche se i nomi, nella Valle, hanno importanza. Ma non ne devono avere per noi. Così il protagonista non ha nome, non lo ha suo fratello, suo padre, i Vecchi dell’Osteria. Non hanno nome sua madre, suo nonno e la prozia svanita suicida.
E allora la Valle a poco a poco diventa qualcosa di diverso. Diventa un luogo interiore, profondo come le miniere, selvaggio come la montagna. Diventa un contenitore di Storie, di ricordi. Ricordi con cui fare i conti. Memorie ancestrali che in qualche maniera appartengono alla vita di ciascuno di noi e che in qualche maniera, prima o poi, devono essere affrontate. Superate.
Così quando il protagonista lascia la Valle per la città, affronta e supera il suo passato. Mentre chi nella Valle ci resta, quel passato non lo affronta mai. E allora le Ombre diventano le persone che abbiamo perso, diventano rimpianti, diventano cose perse crescendo, diventano giganti dagli occhi verdi che divorano il nostro futuro.
Eppure. Eppure dover sacrificare le nostre memorie per poter andare avanti non è mai facile. È doloroso. È necessario. Ma ci fa sentire soli e ci lascia tra i denti una preghiera e un desiderio: che la mano della Valle ci accarezzi ancora una volta restituendoci anche solo per un attimo quello che abbiamo perso.
Lucio Besana ci porta nel folklore sinistro di un luogo selvaggio ma ci accompagna anche dentro di noi. Dove la differenza tra quello che siamo e quello che vorremmo essere sta tutta nelle Storie che decidiamo di ascoltare. Perché forse tra le ombre dei vivi e quelle dei morti, non c’è poi tanta differenza.
Lo puoi trovare qui:

