Il presente che stiamo vivendo è strano. Talmente strano che ti spinge a guardarti dentro come non hai mai fatto, che ti porta a rivedere diverse delle tue convinzioni. E ti insegna. A me, per esempio, ha insegnato a non parlare di cose complesse se non le conosci davvero a fondo. A non cercare scorciatoie concettuali e mi ha impartito una severa lezione: al momento, non so davvero cosa pensare. Quello che credevo di sapere si è frantumato molto in fretta, quel 21 febbraio.
Mi ero raccontato, con una certa convinzione, che quanto accaduto in Cina non poteva succedere in Italia con le stesse proporzioni perché qui le condizioni di vita erano (sono?) drasticamente diverse. E tutta un’altra serie di sovrastrutture erette sul nulla, su speranze che si camuffavano da certezze. Tutto sbagliato. Ecco la prima cosa che ho imparato. Ecco perché di tutto ciò che stiamo vivendo parlerò, forse, poi. In un poi indeterminato, quando sentirò che ci siamo riappropriati almeno di una parte della nostra vita.
Il presente è anche talmente strano che ti spinge a parlare di te su un sito nel quale non parli mai di te. Un sito su cui scrivi di cinema, di libri, di riflessioni, di sogni letterari, ma mai di te, di quello che pensi dentro. Ed è talmente strano che poi ti costringe a fare i conti con ciò che sei. Già, cosa sei?
Io ho una formazione scientifica e la passione per la scienza, nelle sue più varie declinazioni, ha contraddistinto i miei percorsi di studi, parte dei miei tentativi universitari e guida anche il mio modo di scrivere fantascienza. Quindi più di una passione: ero convinto di avere nell’approccio scientifico un timone saldo da impugnare sempre e comunque. Aggiungo: sono ateo ed essere atei non è una scelta, così come non è una scelta credere. È una cosa che succede e basta. Scienza e ateismo: sembro uscito dall’illuminismo, no?
Quando tutto questo è iniziato, quando ci siamo messi in pausa, quando abbiamo sospeso parte della nostra vita in un’attesa che dura ancora, ho però scoperto una cosa. L’ho scoperta poco a poco. Premetto: sono una persona curiosa, molto curiosa. Seguo economia (pur capendone poco), seguo la televisione in tutte le sue declinazioni più oscure, seguo la politica, la geopolitica, mi interesso di religione, letteratura e limitatamente al tempo che resta di filosofia. Poi sono un informatico e il lavoro mi porta e frequentare anche quella parte di mondo. Perciò prima del 21 febbraio e anche i giorni immediatamente successivi, ho letto praticamente tutto quello che potevo sul Covid-19. Mi sono aggrappato alle statistiche, alle indagini scientifiche, a quel confusionario tutto e contrario di tutto che in quelle giornate frenetiche ha saturato tutti gli interstizi del tempo.
Poco più di un raffreddore. Una brutta influenza. Stiamo a casa. Usciamo. E così via. Ho, in sostanza, applicato i miei vecchi schemi. Curiosità scientifica, curiosità in generale. Leggere, sapere, informarsi il più possibile. Ma non mi è servito. Non è servito a nulla. Ho osservato con invidia amici e conoscenti che facevano appello alle loro capacità analitiche per dare un senso ai numeri e ho capito che per loro funzionava. Che l’approccio scientifico, in effetti, funziona. Ma non per me. Me ne sono allontanato, mi sono allontanato dalla mia curiosità per sollevare un muro a protezione dalle informazioni che hanno sempre fatto parte del mio quotidiano. A mia discolpa posso dire che l’offerta non era poi così varia, che era (è) difficile trovare molto altro.
Al contrario, un giorno dopo l’altro, ho iniziato a scoprire che non era l’approccio scientifico a darmi sollievo. Ma quello empatico. Ho trovato in tutte le piccole/grandi manifestazioni di socialità positiva un balsamo emotivo per la difficoltà del momento. Un sorriso dall’altra parte della strada (quando si poteva uscire), la voglia di stare insieme pur essendo distanti, la riaffermazione dell’uomo ‘animale sociale’, pur limitatamente a quello che ci sta capitando. E ho accettato di essere fragile a questo modo. Ho accettato di commuovermi per ‘l’andrà tutto bene’ scritto su un arcobaleno. Ho accettato di commuovermi per gli 8000 volontari che hanno risposto alla chiamata rinnovando quel giuramento – che NON È solo su carta – alla base del lavoro di ogni medico. Ho accettato i miei limiti, ho accettato di essere cambiato e accetto anche il fastidio per alcuni atteggiamenti che vedo. Una banalità? Forse. Ma quando si scopre che una parte di sé non è ciò che si credeva, credo non sia mai una banalità.
Con questo cosa voglio dire? Niente. Sono tempi strani, e nei tempi strani si possono condividere parti di sé attraverso la scrittura perché tradurre una cosa, scolpirla una frase dopo l’altra, vuol dire comprenderla meglio. E in questo momento, per me, la comprensione è una delle cose più importanti.


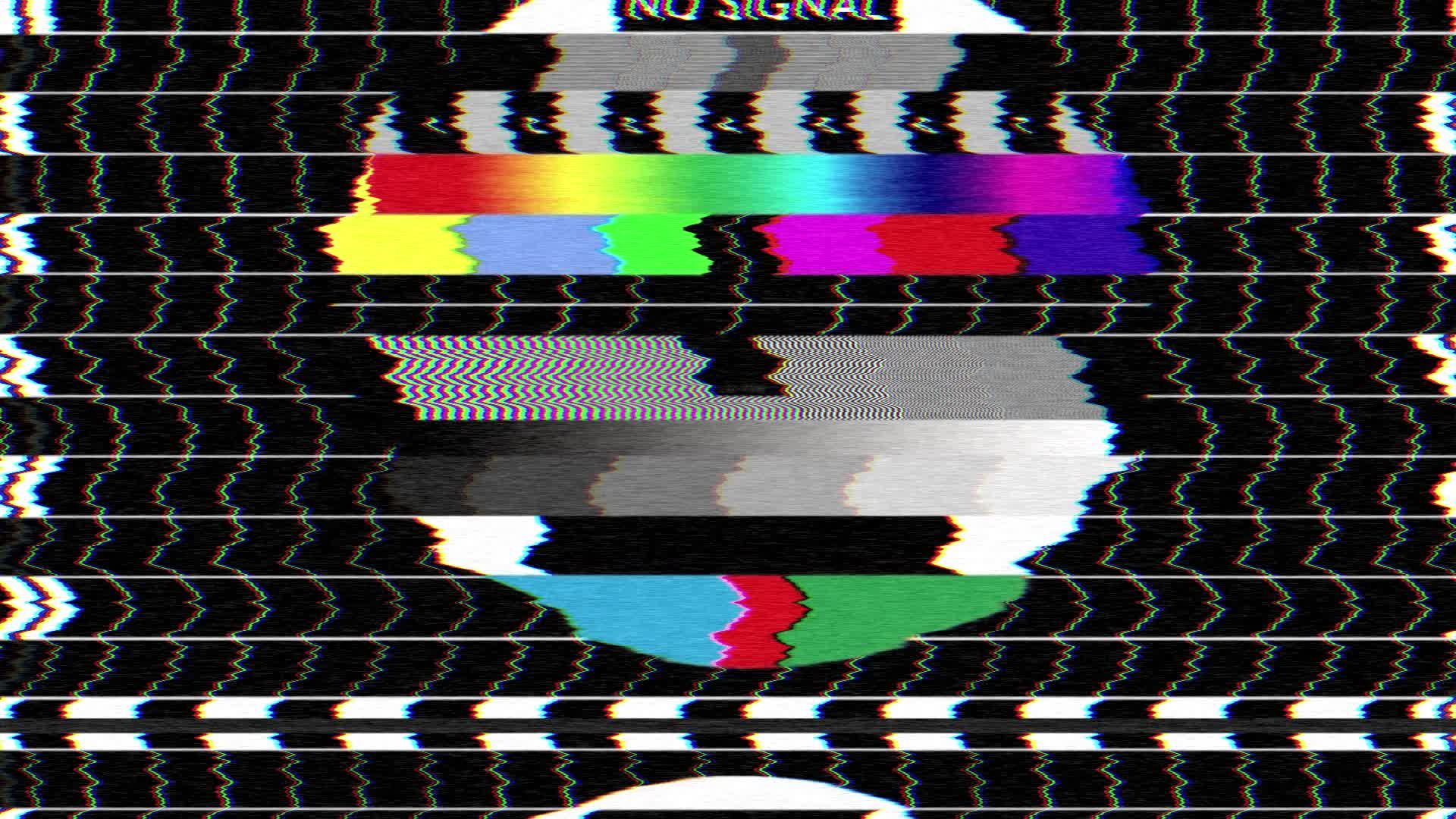
2 Comments
Steffy
Ribadisco, in tutta questa storia tutti impareremo molto, di quel tipo di imparare che non è volontario, ma obbligatorio, di quel tipo di imparare che copre gli aspetti più svariati delle nostre vite interiori o esteriori, pratiche o trascendenti. Esseri umani improvvisamente pienamente consapevoli della nostra vulnerabilità.
Sonia
Ti voglio bene, benissimo