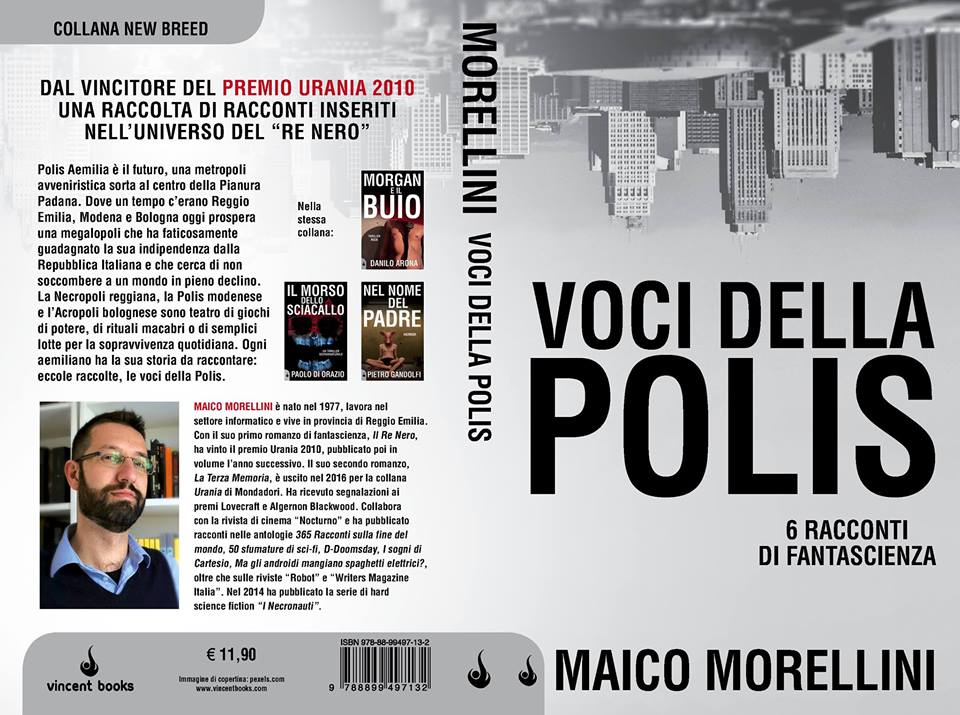Ho scritto questo brevissimo racconto per il bel progetto della fanzine cartacea SP15 e a distanza di quasi un anno lo pubblico qui. In Maya riprendo una leggenda locale che riguarda il Lago Calamone declinata un po’ alla mia maniera. Buona lettura!
L’uomo rimase nascosto tra gli alberi. Rimase lì anche quando il sole scivolò oltre le montagne che accoglievano il lago Calamone. Anche quando le luci del rifugio si spensero trascinando nel buio echi che sapevano di vino, di birra e di allegria.
Rimase nascosto perché aveva bisogno di restare solo, perché doveva vedere le ombre prima allungarsi e poi accorciarsi, stiracchiate dalla luce lunare. Era questione di tempo, come ogni cosa, era solo questione di tempo. Ma doveva restare lì ancora per un po’.
Quando aveva visto per la prima volta il lago? Quando aveva capito?
Setacciò la memoria in cerca di qualche ricordo ma trovò solo manciate di limacciosa ossessione. Si strinse ancor di più le ginocchia al petto mentre una lieve brezza strofinava i rami.
– Non importa – mormorò. Le parole si mescolarono al brusio che animava le fronde. – Non importa – ripeté.
Una lama color latte restituì un po’ di verde alle punte degli alberi. Si trasmise come una vibrazione silenziosa arrivando a illuminare, poco alla volta, l’intero fianco della montagna: la Luna era sorta. La luce proseguì, rallentò, poi riprese la corsa e alla fine baciò anche l’acqua del lago. L’uomo si alzò sciogliendo le braccia dal nodo nel quale si era rifugiato fino a quel momento e allungò il collo verso le acque argento: riconobbe le ninfee sbocciate, piccoli pozzi d’avorio che restituivano alla Luna parte del suo brillare. Spostò lo sguardo verso il centro del lago inseguendo il tocco lunare e trattenne il fiato quando gli occhi raggiunsero prima l’isola e poi il santuario.
Ora ricordava perché era lì. Ora ricordava perché aveva aspettato quella fresca sera di giugno per raggiungere il lago e attendere la notte nascosto tra gli alberi. Ora ricordava.
C’era una leggenda, un mito centenario. Il lago Calamone, secondo gli antichi, era senza fondo. Stretti cunicoli penetravano la montagna, si insinuavano come radici d’acqua tra le rocce e scendevano sempre di più fino a raggiungere il mare. Un contatto tra mondi diversi: quello quieto e silenzioso di un lago di montagna e quello furioso, indomabile e selvaggio degli abissi marini. Due lati di uno stesso specchio.
Ma l’indole umana non sapeva accontentarsi, doveva per forza cercare qualcosa oltre lo specchio. Perciò il lago era tornato a essere un semplice lago: come avevano dimostrato misurazioni scientifiche non era senza fondo, non raggiungeva il mare e, per quanto grazioso, la sua poesia finiva con i cambi di stagione.
Qualcuno però aveva costruito un santuario sulla piccola isola che decorava il lago, una torre in miniatura sormontata da una croce e avvolta da un’ispida corona di cespugli. Un modesto avamposto mistico incastrato sulle acque: non era un caso. Non per lui.
Se aveva imparato qualcosa dopo l’incidente era proprio che dietro ogni leggenda, per quanto assurda o ingenua possa sembrare, ci sono sempre sfumature a cui prestare attenzione. Forse le profondità del lago non erano la congiunzione tra i monti e il mare ma di certo mettevano in contatto due mondi molto distanti tra loro.
Uscì dall’intrico di rami che lo aveva protetto fino a quel momento e scivolò lungo il fianco della montagna. La discesa era dolce e lo condusse fino a un folto canneto animato dal debole vento serale. Annusò l’aria e la trovò carica di promesse: aveva aspettato tanto e quella era finalmente la sua notte.
Superò il canneto senza staccare gli occhi dal santuario e quando arrivò abbastanza vicino all’acqua si chinò e immerse le mani: era fredda, ma non come si sarebbe aspettato. C’erano un’energia e un sapore che non avrebbe saputo descrivere a parole.
– Per questo sono qui – sentenziò rivolto alla notte. Sentì lacrime scendere lungo le guance fino a perdersi in una folta barba che da molto tempo non tagliava.
Maya non aveva mai sopportato la sua barba. Per questo aveva smesso di curarla dopo che lei se n’era andata.
Riprese a camminare zoppicando appena, la gamba destra che faticava a tenere il passo. Seguì il perimetro del lago ma evitò di incrociare il proprio riflesso nell’acqua: non aveva alcuna importanza. Non gli interessava più sapere cosa era diventato, come il dolore si era insinuato sotto la pelle, tra muscoli e ossa. A volte si immaginava come un teschio con poca carne attaccata, altre volte sognava di avere una saggezza senza tempo nello sguardo.
“Sembri più vecchio. Sembra tu abbia vissuto almeno tre vite e mezzo” lo scherniva Maya quando gli rubava qualche sguardo, quando gli frugava negli occhi di nascosto.
– Sono morto, Maya. Sono morto e non ricordo più cosa vuol dire essere vivi – mormorò mentre abbandonava la stretta spiaggia color avorio, mentre imboccava il sentiero fatto di riflessi che lo portava all’isola.
Quando si trovò immerso nell’acqua fino a metà coscia una piccola stilettata di un dolore bianco gli affondò nel ginocchio: si fermò. Ebbe una vertigine, perse il contatto con il fondo melmoso del lago e chiuse gli occhi. Si sentì cadere all’indietro mentre un fragore carico di sofferenza gli sgorgò fuori dalla testa andando a riempiere i silenzi delle montagne.
Aprì la bocca ma sentì solo il sapore metallico del sangue, le braccia incastrate tra le lamiere, le gambe che cercavano disperate di trasmettergli un dolore che l’adrenalina rifiutava. Arrivò il freddo, arrivò l’acqua del fiume. Lo avvolse, soffocò il grido prima che uscisse dalla bocca.
Maya. Maya. Maya.
Riaprì gli occhi.
Maya era morta annegata. Maya aspettava loro figlio.
Ricordava poco dell’incidente in macchina ma di certo non avrebbe voluto sopravvivere. Non avrebbe voluto continuare, non dopo quello che aveva visto poco prima di perdere i sensi, poco prima che lo strappassero alla ricompensa della morte.
Riprese a camminare, il dolore al ginocchio sedato dall’acqua fredda del lago. Le scarpe affondarono nel fango e allora le sfilò, perse l’equilibrio, accolse la luce liquida e l’abbraccio della Luna. Cacciò la testa sott’acqua nascondendosi dal rumore del vento, dalle grida di qualche uccello lontano, dal rombo di un aereo. Nuotò verso l’isola sentendo che una corrente invisibile lo spingeva e a ogni bracciata tra la schiuma e le bolle immaginò il volto di Maya.
La vide accanto a lui, intrappolata, il viso ferito. La vide mentre il gelo azzurro del fiume la racchiudeva in un bozzolo grigio. Contò le bolle d’aria che uscivano dalla bocca di Maya e gridò bevendo il fiume quando l’ultima sfuggì dal parabrezza in cerca della superficie.
Fu allora che le vide, che le sentì, poco prima di perdere i sensi, poco prima che lo salvassero. Prima ombre. Poi luci. Il volto del figlio mai nato. La voce di Maya.
“Sembri più vecchio. Sembra tu abbia vissuto almeno tre vite e mezzo”.
Raggiunse l’isola, uscì dall’acqua. Stava piangendo, il caldo delle lacrime graffiava cercando di raggiungere i tendini. Si tolse i vestiti registrando senza emozione che faceva freddo e li abbandonò sulle rocce. Poi si sedette accanto alla piccola torre di pietra, annodò le braccia intorno alle gambe e aspettò che il lago ritrovasse la quiete.
– Per questo sono qui – ripeté.
Fu allora che accadde. Il riflesso del santuario tremò come se una creatura enorme si fosse mossa sotto il pelo dell’acqua. I contorni di pietra si assottigliarono fino a dissolversi in una macchia liquida e grigia mentre forme cangianti fatte di volti, voci, sorrisi e sofferenza si inseguivano dentro e fuori dall’acqua.
Questo era il vero senso della leggenda, ne era certo. Il lago non univa le sue profondità con quelle marine ma apriva un varco tra il mondo dei vivi e quello dei morti.
Tra lui e Maya. Tra lui e suo figlio.
L’acqua gli aveva strappato via Maya, l’acqua l’avrebbe riportato da lei.
“Sembri più giovane” un sussurro sgorgò dalle bolle silenziose. Le stesse bolle che avevano strappato gli ultimi respiri a Maya.
– Sei tu? – si alzò. – Sei proprio tu? – per la prima volta dopo molto tempo le lacrime non lo tagliarono ma anzi guarirono ferite che in tre anni si erano spinte troppo, troppo in profondità. – Hai visto? Ho la barba ora – si sfiorò il volto e fece un passo avanti.
Le forme si agitarono creando piccoli vortici e il lieve gorgogliare riecheggiò con forza aliena attraverso le montagne. Poi tutto si fermò, come se la natura stessa fosse in attesa: l’assottigliarsi del confine tra vita e morte era più importante di ogni altra cosa.
Ci fu un bagliore e dalle profondità senza nome del lago emersero due volti, pallidi come la consistenza dei desideri.
– Maya – sussurrò. Era lei. Era davvero lei. – Luca? – pronunciò per la prima volta dopo tre anni il nome del figlio mai nato. L’immagine pura del bambino sorrise e lui seppe che non gli serviva altro. Che la magia del lago si era compiuta.
Si lasciò cadere e quando l’acqua lo avvolse lasciò che l’abbraccio lo portasse oltre le profondità.